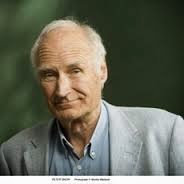Chi non conosce Welsh alzi la mano, e chi l'ha alzata corra in libreria a porre rimedio. Irivine Welsh è una sorta di miracolo letterario, oltre che un ossimoro vivente: scrive in uno slang tossico-edimburghese al limite del compensibile (i suoi traduttori in tutto il mondo sono figure eroiche, come il nostro Massimo Bocchiola) e con una solidità strutturale di fondo assolutamente incredibile, i suoi personaggi e le sue storie sono deviati, tossici, maniaci, perdenti, ubriaconi, caricature del peggior sottoproletariato violento scozzese, gentaccia che si perde in storie folli, sbilenche e sgangherate, eppure non c'è libro di Welsh che non finisca con l'aprirsi in improvvisi sprazzi di profondità totalmente inattesi. Verrebbe da dire che Welsh è un genio letterario suo malgrado. All'apparenza i suoi libri paiono talmente immediati da sembrare improvvisati, raccontano storie così assurde da risultare, ad un primo impatto, inverosimili, eppure non sono molti gli autori al giorno d'oggi da potersi permettere dei libri tanto riusciti come quelli del bardo scozzese. Realista kitsch? Poeta del sottoproletariato? Omero di un'infinita odissea tossica? Welsh è questo ed altro ancora. Ci ha portati per mano a conoscere il mondo dei tossici scozzesi, le loro vite e i loro sogni insostenibili (o la loro insostenibile mancanza di sogni sostenibili) con il suo stile basso, diretto e comico, urlato e involontariamente malinconico. Alla base di tutte le sue storie ci sono le vite dei personaggi, vite prese alla leggera, esistenze già segnate in partenza o che si incastrano in incubi assurdi poco alla volta, scelta sbagliata dopo scelta sbagliata, incastro dopo incastro. Questo Godetevi la corsa non si distanzia dalla poetica degli altri libri di Welsh, e come in altri casi anche in questo libro appare, anche se in un ruolo di semplice comparsa di fondo, uno degli immor(t)ali protagonisti di Trainspotting, in questo caso SickBoy, divenuto imprenditore di successo nel mondo dei video pornografici di Londra. Il protagonista invece è Terry "Gas" Lawson, nuova entrata nel pantheon welshiano, tassista e attore porno, bellimbusto senza arte nè parte, tutto riccioli e "pacco", spacciatore a tempo perso, sciupafemmine per vocazione e "ripopolatore" di Edimburgo e dintorni (i figli leggittimi e non, non si contano) proprio come il suo odiato padre Henry. Lo seguiamo nella sua discesa da una spensierata e scopereccia quotidianità agli inferi dell'astinenza sessuale coatta (causa un muscolo cardiaco ridotto a brandelli) ed alle conseguenze che questa porta, come un uragano, nella sua e nelle vite di chi gli ruota attorno. L'uragano che si abbatte su Edimburgo all'inizio del libro, affettuosamente (ed esorcisticamente) ribattezzato "Du'palle", non è altro che l'incarnazione reale del trambusto che scuote interiormente il protagonista per tutto il romanzo. Terry salverà una ragazza in procinto di suicidarsi, diventerà amico e "socio" di un miliardario americano della tv, farà da supervisore al vice-pappone di un bordello, cercherà, senza troppa foga a dire il vero, una ragazza scomparsa (Jintina) la sera in cui Du'palle si sfoga sulla città, ragazza che è la compagna di un suo cugino mezzo scemo (cugino per modo di dire, se leggerete il libro, capirete) nonchè prostituta - per necessità ma anche per vocazione - e infine sua amante occasionale (in realtà si tratterà solo di "una botta e via", ma tant'è), aiuterà il miliardario americano a trovare una bottiglia di costosissimo whisky per collezionisti appena comprata e subito rubata, diventerà un ottimo giocatore di golf, cercherà di rimediare ai suoi errori passati redimendosi come buon padre e pessimo figlio, scoperchierà tombe e, addirittura, si taglierà i suoi leggendari riccioli accalappia-femmine, inizierà il suo cugino "mongo" al mondo del porno, e via discorrendo. Entrare oltre nella trama vorrebbe dire svelare anche solo un singolo ganglio dell'intreccio, e sarebbe già troppo. Se il protagonista è indubitabilmente Terry Lawson (e in un certo senso anche il suo "Vecchio Compare"), le voci narranti sono diverse: oltre Terry, c'è Jontino (il cugino cui manca qualche Venerdì), Jintina (la di lui compagna, prostituta e persona scomparsa) Ronnie Checker (il miliardario americano, star dei reality televisivi) e, in un paio di occasioni, addirittura "il Vecchio Compare". Se vogliamo elencare quello che capita in questo romanzo, è più facile ribadire ciò che non succede: non ci sono invasioni aliene e non crollano le Torri Gemelle. Al di là della trama, apparentemente estemporanea (non lo è, al contrario, è ben salda) ma comunque assolutamente secondaria se non in funzione di divertissement, il centro del libro sono Terry e la sua psicologia, comunque piuttosto sorprendente per essere l'emanazione di un tipo sociale (all'apparenza) parente strettissimo dell'australopiteco. Terry si barcamena in un contesto sociale in cui la violenza è il mezzo più comune per rapportarsi col prossimo e, al contrario di quanti gli stanno attorno, lo utilizza soltanto come extrema ratio. Il sesso per lui non è una perversione nè un commercio, ma il momento vitale che dà significato a tutti gli altri. Nel cercare sè stesso, nel tentativo di definirsi come "altro" da suo padre, incorrerà in una serie interminabile di accadimenti deliranti e in una scoperta devastante che lo porterà ad una rivoluzione copernicana nel percepire sè stesso, e il tutto senza l'ausilio della sua droga preferita, il sesso. Alla fine, scoprirà che essere Terry Lawson, alla fine, con tutti i suoi difetti e le sue mancanze, non è la cosa peggiore che gli potesse capitare. Questo Godetevi la corsa, è un libro straordinariamente divertente, lessicalmente devastato e devastante, sicuramente non il capolavoro di Welsh, ma comunque una folle cavalcata nei bassifondi di Edimburgo e dell'anima di Terry Lawson, un personaggio che non sarà facile dimenticare (se non è all'altezza dei leggendari SickBoy, Marc Renton, Spud e Franco Begbie (il generalissimo Franco!) è solo perchè il contesto letterario nel quale Welsh lo immagina non è Trainspotting).
Irvine Welsh: cresciuto in
un quartiere di case popolari, abbandona presto la scuola
per intraprendere vari lavori, tra cui lo spazzino (ruolo in cui comparirà in un cameo nel film The Acid House). Nel 1976 si trasferisce a Londra e aderisce alla rivoluzione
punk e comincia a sperimentare diverse sostanze
stupefacenti. Ormai ex-tossicodipendente, Irvine Welsh
comincia a scrivere mentre era ai servizi sociali, dopo aver letto il
romanzo Dockerty (1975) di William McIllvaney. Scrive Trainspotting cercando di ricreare l'eccitazione che si prova
andando a un rave o in un club house e utilizzando il dialetto scozzese,
perché più funky rispetto allo Standard English.
Trainspotting, Ecstasy, Acid house, Il lercio, Tolleranza zero, Colla, Porno, I segreti erotici dei grandi chef, Una testa mozzata, Crime, Tutta colpa dell'acido, Serpenti a sonagli, Skagboys e La vita sessuale delle gemelle siamesi, tutti per Guanda.
"E di colpo percepisce in quella dichiarazione una minaccia. Qualcosa che si avvicina dalla parte del mare. Qualcosa che avanza trascinato dalle nubi scure che attraversano invisibili la baia di Acapulco."
Roberto Bolano, (da Ultimi crepuscoli sulla terra; Puttane assassine)
Roberto Bolano, (da Ultimi crepuscoli sulla terra; Puttane assassine)
domenica 17 maggio 2015
domenica 26 aprile 2015
Le scimmie, di Josè Revueltas, Sur editore
Tutto il respiro del racconto è cinto tra le sbarre di una prigione e quelle di una manciata di minuti, pochi, spesi in attesa della Meche, della Chata, della Madre e della droga che quest'ultima nasconde all'interno della sua vecchia ed immonda vagina. Sono Polonio, Albino e il Coglione che si struggono in attesa di quella manciata di polvere bianca che è, per loro, l'unica via di fuga dal carcere e, soprattutto, da sè stessi. Prima Polonio, poi Albino e infine il Coglione infileranno la testa nello spazio stretto e umiliante dello spioncino per controllare, con l'unico occhio che riesce ad averne la visuale, il cortile sottostante, in attesa dell'entrata dei parenti dei detenuti. Poi i parenti entreranno, e con loro le tre donne, e infine succederà quello che succederà. Stop, fine. Tutto qui. Eppure questo Le scimmie è un viaggio in un'altra dimensione, non tanto fisica (il carcere, o cubo, come viene definito nel racconto), quanto spirituale. La descrizione del Coglione è quanto di più straziante e realistico si possa immaginare, e lo stesso vale per la Madre (del medesimo): il loro legame, fatto di ripugnanza, sensi di colpa, inadeguatezze, finanche di tenerezza, e poi ancora rabbia, codardia, rimpianto e sconfitta, è il riassunto della condizione umana secondo la concezione di José Revueltas. Il fatto stesso di aver partorito quell'obbrobrio che risponde al soprannome di "Coglione" richiama immediatamente nell'autore l'immagine di un coito bestiale della madre, consumato con chissà chi, in chissà quali sordide circostanze. Non c'è spazio per l'amore, solo per il brutale desiderio, non c'è speranza e, soprattutto, non c'è redenzione. Siamo nel braccio più patetico dell'intero carcere, quello dei tossicodopendenti, degli sfigati, di esseri totalmente in preda ai propri istinti primari, incapaci di elevarsi dal proprio livello (para)bestiale: Polonio e Albino dividono la cella con il Coglione, uno sciancato, zoppo e orbo, che ogni tot tempo si apre le vene in attesa che le guardie - le scimmie del titolo - corrano a salvarlo. In fondo vorrebbe morire, così come pure sua madre prega che la morte abbia pietà di lui e se lo porti via (da notare, nel testo, che si tratta sempre di supposizioni della voce narrante, vale a dire dello stesso Revueltas, disgustato dall'umanità che descrive ma al contempo incapace di condannarla), ma in fondo legato inconsapevolmente a quella sua ridicola e abietta parvenza di vita, vita da vittima, da reietto, da disgustoso purulento. I tre detenuti e le tre donne che vanno a trovarli (compagne e madri), e le scimmie, che camminano da un lato all'altro del corridoio, che passano la vita all'interno del carcere esattamente come coloro ai quali devono limitare la libertà, carcerati essi stessi, ma per scelta: questa è l'umanità che si muove sul palcoscenico di Revueltas, il cubo, di cui noi per buona parte del racconto non possiamo che scorgere un semplice rettangolo che la testa di Polonio riesce, a fatica, a sbirciare. L'autore non giudica, nè assolve, si limita a descrivere, ma non tanto la realtà che il suo occhio di compagno di sventure (l'autore scrive questo racconto durante la sua ultima detenzione, nel 1968) può registrare, quanto l'universo valoriale che sta dietro a quell'umanità. Se nella narrazione non è presente la condanna è però imperante un senso di consapevolezza che diventa il grimaldello principale per scardinare da una banale cornice realista quello che avrebbe potuto essere un semplice racconto (quasi un articolo di cronaca) ed elevarlo a letteratura universale: quei minuti, quei pochi personaggi, quello spazio ermeticamente chiuso, sono l'esistenza, lo stato del transito umano in questa realtà. Il Particolare (tra l'altro, così... "particolare") che racchiude in sè l'Universale. La consapevolezza dell'autore di avere di fronte agli occhi non solo, e non tanto, una pessima (messa in)scena di una squallida porzione di umanità, bensì il succo stesso dell'essere umano, lo porta ad abbandonare la descrizione realista e a giungere ad un turbine stilistico che non di rado scivola piacevolmente nella filosofia (del suo autore) e nella (anti)psicologia dei suoi personaggi. Loro, le scimmie, Polonio, Albino, il Coglione e le loro donne non si rendono conto di niente, a malapena di sè stessi, ma senza comunque arrivare mai a comprendersi, sono burattini schiavi delle proprie pulsioni: la droga, il sesso, il disgusto, la vendetta, la sopravvivenza. Non c'è altro. A ben vedere non c'è, non dico la speranza, ma neppure il sogno sedativo di una fuga, di un futuro fuori dal carcere. L'unica fuga è la morte, in fondo agognata, per gli altri e, a volte, per sè stessi, ma in fondo scansata (non temuta, scansata, quasi con noncuranza). Oltre le mura del carcere le menti dei protagonisti non riescono più a figurarsi nulla: qualche brandello di ricordo, di passato, ma il futuro è un oceano scuro, privo di dimensioni che non vale neppure la pena di essere preso in considerazione. Di tutto questo, della vita che scorre nelle loro vene, nè tantomeno di concetti più elevati, nei tre non esiste traccia di consapevolezza alcuna. Esistono, senza saperlo. Uccidono (o vorrebbero farlo) senza indagarne il motivo. Scopano senza altro trsporto che non sia un desiderio animale, equivoco, malato. Solo la droga permette loro dei temporanei perimetri di requie ai propri demoni.
Era tutto un non rendersi conto di niente. Della vita. Senza rendersi conto se stavano lì, dentro il cubo, marito e moglie, marito e marito, moglie e figli, padre e padre, figlie e genitori, scimmie atterrite e universali.
(pag.20)
La scrittura di Revueltas è un vortice, uno sguardo furioso, disgustato e attonito che, mentre descrive, ragiona, entra nelle psicologie dei personaggi e le trova (spazi, stanze) vuote, povere, maleodoranti, malconce, disperate, è una cavalcata che mescola punti di vista e sensazioni, pensieri, riflessioni, senza mai un attimo di tregua, lunghi periodi che evitano (per un pelo) la prolissità del narrare barocco grazie ad un poeticità che pur nella bassezza del materiale riesce a trovare un punto di equilibrio musicale (avete presente la nona sinfonia di Beethoven che accompagna le gesta dei drughi di Arancia meccanica?). Sono solo 51 pagine, ma di letteratura a tutto tondo.
José Revueltas (1914-1976), scrittore, sceneggiatore e attivista politico, è considerato in Messico un autore di culto. Ha scritto più di trenta libri tra romanzi, racconti e saggi politici.Qui potete trovare articoli ed approfondimenti sull'autore, nelle pagine del blog di Sur Edizioni.
Era tutto un non rendersi conto di niente. Della vita. Senza rendersi conto se stavano lì, dentro il cubo, marito e moglie, marito e marito, moglie e figli, padre e padre, figlie e genitori, scimmie atterrite e universali.
(pag.20)
La scrittura di Revueltas è un vortice, uno sguardo furioso, disgustato e attonito che, mentre descrive, ragiona, entra nelle psicologie dei personaggi e le trova (spazi, stanze) vuote, povere, maleodoranti, malconce, disperate, è una cavalcata che mescola punti di vista e sensazioni, pensieri, riflessioni, senza mai un attimo di tregua, lunghi periodi che evitano (per un pelo) la prolissità del narrare barocco grazie ad un poeticità che pur nella bassezza del materiale riesce a trovare un punto di equilibrio musicale (avete presente la nona sinfonia di Beethoven che accompagna le gesta dei drughi di Arancia meccanica?). Sono solo 51 pagine, ma di letteratura a tutto tondo.
José Revueltas (1914-1976), scrittore, sceneggiatore e attivista politico, è considerato in Messico un autore di culto. Ha scritto più di trenta libri tra romanzi, racconti e saggi politici.Qui potete trovare articoli ed approfondimenti sull'autore, nelle pagine del blog di Sur Edizioni.
Etichette:
José Revueltas,
Le scimmie,
Libros,
Sur editore
venerdì 17 aprile 2015
Quando siete felici, fateci caso, di Kurt Vonnegut, Minimum Fax editore
Se non avete mai letto nulla di Vonnegut, se non avete avuto questa fortuna, fatevi un regalo, e correte a leggerlo. Questo "Quando siete felici, fateci caso" (titolo originale: If this isn't nice, what is?) raccoglie nove discorsi che vanno dal 1978 al 2004 (Vonnegut morirà tre anni dopo, l'11 Aprile del 2007) e, come ogni testo uscito dalla penna dello scrittore di Indianapolis, fosse pure lo scontrino della spesa, è una buona notizia per la letteratura in generale e per l'equilibrio mentale di noi lettori in particolare. Una nota per chi non lo conoscesse: non fatevi ingannare dal titolo, non è un manuale di auto aiuto nè nulla di simile, neppure lontanamente. E' letteratura, alta letteratura, tra la migliore che il novecento americano abbia prodotto, e comunque leggere Vonnegut è un'esperienza salutare per chiunque. Kurt Vonnegut è stato uno scrittore "irregolare", tra i più "irregolari" che si possano ricordare, a partire dalla sua formazione di stampo scentifico (come Pynchon ad esempio, per rimanere nell'ambito dei grandissimi, ma a differenza del genio di Glen Cove non è possibile collocarlo totalmente nell'ambito letterario del postmoderno, così come d'altronde non è etichettabile neppure come semplice scrittore di fantascienza): capace di una prosa semplice e soprattutto diretta e dotato di una fantasia pressochè illimitata (oltre alla sua produzione vanno considerate le trame che di volta in volta addebita a Kilgore Trout, lo scrittore - alter ego che spesso compare nei suoi libri) che lo ha portato a sfruttare il contenitore della science-fiction come personale campo di giochi per parlare dell'essere umano e dei suoi limiti, della vita e del terrore che essa incute a chiunque abbia la sventura di provarla sulla propria pelle. Grazie ad un eccellente e spiazzante senso dello humor non scade mai nel pessimismo più o meno "cosmico" di altri autori, ma riesce a riportare il passaggio degli esseri umani sul pianeta Terra in tutta la sua traballante, e a volte comica, incertezza. I protagonisti di Vonnegut, che siano umani o para-umani, sono sempre esseri impacciati persi nei loro balbettii alla ricerca di qualcosa che nella sua stessa tragicità svela la propria imbarazzante banalità. Lo sguardo di Vonnegut non è quello di un antropologo su Marte (parlo di antropologia non a caso, dal momento che l'autore ha frequentato la facoltà di Antropolgia, a Chicago, e questo tipo particolare di sguardo lo si sente in tutta la sua produzione), bensì quello di un antropologo da marte: il suo è lo sguardo di Dio verso le sue creature, uno sguardo sconsolato ma in fondo benevolo. I nove discorsi di questa raccolta riportano chiaramente tutti i pilastri del Vonnegut uomo e scrittore: il suo essere umanista (io in certi casi lo definirei "amabilmente anarchico", ma lui non si definisce mai così), i suoi figli, Indianapolis e le scuole che lì ha frequentato, i professori che lo hanno formato, Gesù (inteso non come Dio, essendo Vonnegut un tabagista ateo, ma come uomo dotato di buon senso, capace di dare all'umanità uno dei pochi discorsi degni di essere ascoltato, il Discorso della montagna), l'America e il tradimento dei suoi valori, l'importanza di una comunità in cui riconoscersi e di una famiglia allargata nella quale crescere, trovare e fornire protezione, Mark Twain, la seconda guerra mondiale (nella quale ha combattuto) e il bombardamento di Dresda (al riguardo, leggetevi Mattatoio n.5 o la crociata dei bambini, il suo capolavoro), i suoi zii e i loro consigli, tra cui, appunto: se siete felici fateci caso, si trattasse anche solo di una limonata fresca o del suono di un pianoforte suonato dal vicino di casa. Fosse anche solo la sensazione del calore sulla pelle lasciata dai primi raggi di sole della primavera, Kurt Vonnegut, anzi suo zio, ci prega di rendercene conto.
Qualche esempio di cosa sia il Vonnegut (life) style:
Il vero terrore è svegliarsi una mattina e scoprire che i tuoi compagni delle superiori stanno governando il paese.
Chi crede nella telecinesi, mi faccia alzare la mano.
Un'altra pecca nell'indole degli esseri umani è che tutti vogliono costruire e nessuno vuole fare manutenzione.
Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di petrolio.
La vita è un pessimo trattamento da infliggere ad un animale
Non c'è motivo per cui il bene non possa trionfare, se solo gli angeli si dessero un'organizzazione ispirata a quella della mafia.
Siamo qui sulla terra per andare in giro a cazzeggiare. Non date retta a chi dice altrimenti.
Se non avete mai letto Vonnegut, questo sarà il primo libro di una lunga serie. Se già l'avete letto, allora siete dei cultori e questa chicca non potrà farvi altro che piacere. Se siete felici, fateci caso è un tassello perfettamente complementare a Un uomo senza patria, del 2006, sempre per Minimum Fax, ma in un certo senso tutta la sua opera è un lungo ininterrotto coerente discorso sullo stato dell'umanità, dall'antimilitarismo alla necessità di "aiutarsi a vicenda a superare questa cosa, qualunque cosa sia".
Sulla non etichettabilità di Vonnegut: troverete diverse pubblicazioni che lo vogliono collocare in qualche angusto ambito letterario: gli amanti della fantascienza lo vogliono scrittore di genere, i beatnick lo elessero a rappresentante della controcultura (fu un mito letterario nelle università americane), gli intenditori lo intendono come rappresentante del post moderno... chiunque ha letto Vonnegut ha cercato di portarlo nella propria squadra, ma Vonnegut, a Dio piacendo, è Vonnegut "un vagabondo spaziale di nome Kurt.
Se posso permettermi un consiglio: leggete Cronosisma. E se l'avete già letto, rileggetelo.
Kurt Vonnegut nasce ad Indianapolis, nello stato dell'Indiana (USA) l'11 novembre del 1922. Scrittore di culto statunitense, appartenente al genere fantascientifico, negli anni 2000 la sua opera ha ricevuto una nobilitazione stilistica importante, che ha reso giustizia al suo profilo di scrittore.
Oltre che afferenti al fantastico, le sue opere sono intrise di sfumature politiche e sociali, talvolta permeate di humour nero, e in grado di fuoriuscire da qualsiasi classificazione di genere, oltre modo limitante.
Per molti critici, Vonnegut è considerato importante soprattutto per le implicazioni di carattere morale di cui è sovente pregna la sua letteratura, soprattutto per quanto riguarda quello che è considerato il suo capolavoro, secondo molti uno dei più bei romanzi mai scritti contro la guerra, "Mattatoio N.5", pubblicato nel 1969.
Qualche esempio di cosa sia il Vonnegut (life) style:
Il vero terrore è svegliarsi una mattina e scoprire che i tuoi compagni delle superiori stanno governando il paese.
Chi crede nella telecinesi, mi faccia alzare la mano.
Un'altra pecca nell'indole degli esseri umani è che tutti vogliono costruire e nessuno vuole fare manutenzione.
Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di petrolio.
La vita è un pessimo trattamento da infliggere ad un animale
Non c'è motivo per cui il bene non possa trionfare, se solo gli angeli si dessero un'organizzazione ispirata a quella della mafia.
Siamo qui sulla terra per andare in giro a cazzeggiare. Non date retta a chi dice altrimenti.
Se non avete mai letto Vonnegut, questo sarà il primo libro di una lunga serie. Se già l'avete letto, allora siete dei cultori e questa chicca non potrà farvi altro che piacere. Se siete felici, fateci caso è un tassello perfettamente complementare a Un uomo senza patria, del 2006, sempre per Minimum Fax, ma in un certo senso tutta la sua opera è un lungo ininterrotto coerente discorso sullo stato dell'umanità, dall'antimilitarismo alla necessità di "aiutarsi a vicenda a superare questa cosa, qualunque cosa sia".
Sulla non etichettabilità di Vonnegut: troverete diverse pubblicazioni che lo vogliono collocare in qualche angusto ambito letterario: gli amanti della fantascienza lo vogliono scrittore di genere, i beatnick lo elessero a rappresentante della controcultura (fu un mito letterario nelle università americane), gli intenditori lo intendono come rappresentante del post moderno... chiunque ha letto Vonnegut ha cercato di portarlo nella propria squadra, ma Vonnegut, a Dio piacendo, è Vonnegut "un vagabondo spaziale di nome Kurt.
Se posso permettermi un consiglio: leggete Cronosisma. E se l'avete già letto, rileggetelo.
Kurt Vonnegut nasce ad Indianapolis, nello stato dell'Indiana (USA) l'11 novembre del 1922. Scrittore di culto statunitense, appartenente al genere fantascientifico, negli anni 2000 la sua opera ha ricevuto una nobilitazione stilistica importante, che ha reso giustizia al suo profilo di scrittore.
Oltre che afferenti al fantastico, le sue opere sono intrise di sfumature politiche e sociali, talvolta permeate di humour nero, e in grado di fuoriuscire da qualsiasi classificazione di genere, oltre modo limitante.
Per molti critici, Vonnegut è considerato importante soprattutto per le implicazioni di carattere morale di cui è sovente pregna la sua letteratura, soprattutto per quanto riguarda quello che è considerato il suo capolavoro, secondo molti uno dei più bei romanzi mai scritti contro la guerra, "Mattatoio N.5", pubblicato nel 1969.
Etichette:
Kurt Vonnegut,
Libros,
Minimum Fax editore,
Se siete felici fateci caso
sabato 28 marzo 2015
Annientamento, di Jeff Vandermeer, Einaudi
Annientamento è il primo libro di una trilogia dedicata all'Area X, ed è un bel libro, ben scritto, piacevole quanto disturbante. Difficile smettere di leggerlo (anche perchè 182 pagine non sono propriamente un traguardo irraggiungibile ai più). Se vogliamo dar retta al Re del Brivido, alias Stephen King (e vogliamo, vogliamo), ci troviamo di fronte ad un racconto "inquietante e affascinante", e in effetti è così. Un particolare: nell'intero libro non incappiamo mai in un nome proprio, e neppure in un cognome se è per questo: ogni personaggio è identificato per il suo ruolo: l'antropologa, la psicologa, la biologa, il marito, e via discorrendo. Non so se sia un record, ma mi pareva giusto sottolinearlo. Allora, l'Area X è una zona del pianeta nella quale le normali leggi fisiche e biologiche non trovano applicazione, comunque non sempre. Accadono fenomeni strani, inspiegabili. E per questo l'area è una sorta di "no fly zone" nella quale l'agenzia governativa incaricata di studiarla, la Southern Reach, invia, una dietro l'altra, diverse missioni composte da scienziati specializzati in un determinato campo (biologi, psicologi, glottologi, topografi), nella speranza di... Ecco il primo mistero: nella speranza di cosa? Di mapparne la zona nella speranza di scoprirne i segreti? Di individuare il fenomeno iniziale che ha cambiato le leggi naturali dell'area? Nella speranza di capire il funzionamento delle nuove leggi? O forse di decriptare misteriosi messaggi che compaiono sulle mura di una sorta di Torre rovesciata scavata nel terreno? O semplicemente gli specialisti inviati non sono altro che offerte sacrificate a... E qui, nel caso venisse sciolto il primo mistero, appare il secondo: offerte sacrificate a chi? O a cosa? E via con le successive domande senza risposta: perchè la maggior parte dei membri delle spedizioni precedenti non ha fatto ritorno? E perchè quelli che sono tornati - senza peraltro conservare il benchè minimo ricordo di come hanno fatto a fuggire dall'Area X - non sono più gli stessi, paiono anzi gusci svuotati? La Southern Reach nasconde forse dei segreti, offre davvero tutte le informazioni di cui è in possesso agli esploratori che invia in missione? In trent'anni, il numero delle missioni è stato - prima di quella oggetto della narrazione - di sole undici, o forse alcune sono state tenute segrete al mondo? Il libro Annientamento, di Jeff Vandermeer, è il diario narrato in prima persona dalla Biologa, che decide di far parte della missione per trovare notizie del marito, membro della missione precedente, tornato a casa senza memoria, svuotato, e poi morto misteriosamente poco dopo. Il rapporto della Biologa col marito era stato anche quello una sorta di guscio vuoto, colmo di silenzi, incomprensioni e quant'altro può riservare un matrimonio non troppo felice pur senza essere un disastro. Cosa è capitato al Marito durante la sua spedizione? E che ruolo ha il Faro nei fenomeni che si ripetono nell'area? Cosa accadde in quel faro, e che fine ha fatto il suo guardiano? Perchè i membri delle varie missioni, in breve tempo, sbroccano di testa e si suicidano, o si uccidono a vicenda, o scompaiono nel nulla (a volte ricomparendo in maniera inspiegabile presso le loro abitazioni solo per fare la figura di zombi smemorati)? Alla fine le domande sono infinite, ma si condensano sostanzialmente in una sola: cosa diavolo capita nell'Area X? Ma questa domanda in realtà, per i membri delle spedizioni, si muta in qualcosa d'altro: li pone di fronte a dubbi, domande, paure e altri mostri che, da qualche parte, si portano dentro e, quindi, in una chiave di lettura classica vuole che ci si domandi: ma l'Area X è fuori o dentro di noi? E se esiste realmente, non è forse una concrezione dei nostri incubi? Ripeto, il libro è ben scritto, di una scrittura tersa (tersa ma pure tesa) ed essenziale, drammatica quel tanto di indispensabile al tipo di narrazione, cassata qualsiasi tipo di ironia, per quanto sottile; e la trama è senza dubbio avvincente, quindi un libro da consigliare, ma. Ecco il ma. Se fosse stato scritto prima della serie culto televisiva Lost, sarebbe stata una pietra miliare del genere, assolutamente. Un fenomeno editoriale eccetera. Ma venendo dopo, rimane "solo" un bel libro (e comunque non è poco). Voglio dire: è Lost, senza isola, senza aereo caduto, ma il meccanismo è lo stesso, le tecniche narrative altrettanto (rimbalziamo tra il presente pieno di mistero e tensione dell'Area e il passato della Biologa, da bambina, da giovane, da moglie). Considerando che la fine della serie televisiva tirava in ballo questioni un tantino nebulose che hanno deluso tanta parte dei fan, e prendendo atto che la fine di questo libro in qualche maniera si ricalca la fine della serie tv, mi domando come verranno affrontati i successivi due libri della trilogia (Autorità - in pubblicazione a Giugno - e Accettazione - in pubblicazione a Settembre). La paura è che scavino in quel territorio informe e allucinato che poco ha a che vedere con il mistero e la logica (e con la logica del mistero) e molto con l'abilità dell'autore di inventare mondi, colori, forme che non esistono e che alla lunga (ma anche non troppo alla lunga) tendono a diventare mortalmente noiosi (in questo primo libro la dose di allucinazioni è calibrata al punto giusto, bisogna ammetterlo). La speranza invece è che le prossime puntate sappiano mantenere alta la tensione e spiattellarci nuovamente un mistero dopo l'altro, magari con qualche cambio di prospettiva che risulti anche un ottimo colpo di scena. Comunque, io aspetto il prossimo volume, e credo che chiunque ha amato Lost e (quindi, giocoforza) amerà questo libro, non potrà far altro che seguire fino all'ultimo le avventure dell'Area X.
Una postilla: la copertina trasparente è fantastica, e le illustrazioni di Lorenzo Ceccotti notevoli.
Jeff VanderMeer è autore di racconti e romanzi con cui ha vinto il BSFA Award, il World Fantasy Award, il Nebula Award, e con cui è stato finalista allo Hugo Award. Scrive per numerose testate fra cui il «New York Times», il «Guardian» e il «Washington Post». Nel 2015 Einaudi ha pubblicato Annientamento, primo volume della Trilogia dell'Area X.
Una postilla: la copertina trasparente è fantastica, e le illustrazioni di Lorenzo Ceccotti notevoli.
Jeff VanderMeer è autore di racconti e romanzi con cui ha vinto il BSFA Award, il World Fantasy Award, il Nebula Award, e con cui è stato finalista allo Hugo Award. Scrive per numerose testate fra cui il «New York Times», il «Guardian» e il «Washington Post». Nel 2015 Einaudi ha pubblicato Annientamento, primo volume della Trilogia dell'Area X.
Etichette:
Annientamento,
Area X,
Einaudi,
Jeff Vandermeer,
Libros
venerdì 20 marzo 2015
Rio Fugitivo, di Edmundo Paz Soldàn, Fazi editore
Rìo Fugitivo, la città che dà il titolo al romanzo, in realtà non esiste se non nella fantasia, fervida, di Roberto, il protagonista. Cochabamba, come tutti sanno, esiste, ed è una città della Bolivia, il teatro dell'azione del romanzo, la città dove Roberto e i suoi amici vivono, crescono e vanno a scuola. Siamo negli anni '80, in quella stretta (strettissima, risicata) fascia sociale che è la buona borghesia boliviana, famiglie che, in un paese piagato dalla povertà e dall'instabilità politica, sempre sull'orlo di un golpe de estado, possono permettersi una vita agiata, una buona istruzione per i figli alla scuola Don Bosco che li destinerà irrevocabilmente ad un futuro alla guida del paese. I loro anni 80 (borghesi, boliviani, cochabambini) sono incredibilmente simili ai nostri: stessi miti, stessi programmi tv importati dagli Usa, capigliature, modi di vestire, gadget: un presente scontento di sè stesso incapace di pensare ad altro se non che il futuro sarà diverso, dovrà esserlo per forza, ma senza saper immaginare come. Negli anni 80, a Cochabamba, al Colegio Don Bosco, Roberto è (era) un bravo ragazzo, per quello che può permettersi di esserlo un ragazzino di quell'età, ma sogna il delitto perfetto in un mondo che non esiste, in una città che non esiste, Rìo Fugitivo appunto, e immagina un ispettore, che non esiste, Mario Martinez, capace di risolverlo. Legge molto, solo gialli (ha saccheggiato quelli letti da suo padre e trovati in casa, e da allora non si separa dal genere), soprattutto Agatha Christie, e vive sospeso in una dimensione dove la divisione tra luce ed ombra, bene e male, "Chinatown" (la zona della classe presidiata dai cattivi elementi) e resto del mondo sfuma continuamente in una twilight zone nella quale ognuno, proprio malgrado, recita una parte (è quella parte, è quella storia che racconta di sè), incapace di capire se sia la parte giusta per sè e soprattutto di scegliersela fino in fondo (siamo noi a decidere chi siamo o non è, forse, l'ereditarietà a decidere al posto nostro, a nostra insaputa?) La famiglia di Roberto è intrappolata in un mondo di sogni mal riusciti: il padre sogna utopie golpiste destrorse, la madre sogna -come per miracolo - di vedere sparire il marito, Silvia, la sorella, sogna che il patrigno (il padre biologico di Roberto e Alfredo) si accorga di lei e si decida a considerarla una figlia e non un'intrusa e, in mancanza delle attenzioni paterne (o forse proprio per attirarle su di sè), non sa decidersi se dedicarsi al suo amore (finto)francese o se dedicarsi anima e corpo all'università, e Alfredo non si sà nè cosa pensi nè tantomeno cosa sogni (si arriverrà a supporlo, almeno questo, alla fine del romanzo). Alfredo è il fratello più giovane di Roberto, ed è un mistero, un angolo nero, un pugno chiuso, ognuno lo vede con occhi diversi, tutti lo interpretano, lui è un vulcano, è simpatico, attivo, ma al contempo sinistro: incendia un prato in cui rimarrà sfigurato un senzacasa, fa uso di sostanze illecite, si eclissa, scivola via dalle attenzioni di una famiglia troppo distratta dai propri problemi, reali o immaginari che siano fa poca differenza, anzi, non ne fà affatto.. Poi muore, Alfredo. Con un alfiere in mano. E ogni cosa cambia, senza in realtà cambiare davvero, almeno apparentemente. Roberto, una volta per tutte, si sente addosso i panni Mario Martinez e Cochabamba si trasforma sinistramente in Rìo Fugitivo (una Twin Peaks - un luogo oscuro dell'anima innanzitutto - in salsa latinoamericana). Chi ha venduto la droga che ha portato Alfredo alla morte? Quale dei compagni? O si tratta della figura (para)leggendaria dello Scacchista? O qualcun altro ancora? Cosa significa l'alfiere stretto nella mano di Alfredo? Chino è colpevole, o lo è Mauricio? Chi è, realmente, cosa? Ma questo splendido romanzo non è un libro giallo, il delitto perfetto non c'è, e se c'è non lo sappiamo, e se anche lo immaginiamo in realtà non frega niente a nessuno: Alfredo è morto per tutta una serie di ragioni e concause che non verranno mai totalmente svelate, punto. Il vero protagonista del romanzo è il romanzo stesso: mi spiego: le storie. Le storie che ognuno dei personaggi racconta agli altri e quelle che racconta a sè stesso. Tutti raccontano (anzi, tutti raccontiamo) una storia ma, soprattutto, tutti sono una storia, anzi, tutti siamo una storia. E la realtà è l'intreccio inestricabile delle infinite storie più o meno innocenti, più o meno manipolatorie che tutti noi raccontiamo e ci raccontiamo. C'è un ma, ossia: quanto, delle storie che siamo, dipende dall'ereditarietà? Vale a dire: le storie che si sono raccontati i nostri avi, e quindi le storie che sono stati i nostri avi, quanto influiscono sul nostro destino, sulle storie che noi, raccontandocele, siamo? In questo senso Rìo Fugitivo è un romanzo sul romanzo: racconta una storia (quindi un intreccio di storie) che si domanda cosa saremmo, se non fossimo storie. E la risposta, come il delitto perfetto, non c'è: è solo un libro, un romanzo, che diventa tale nel momento stesso in cui racconta delle storie, cioè racconta sè stesso. Proprio come capita a noi.
Edmundo Paz Soldán
Nato
a Cochabamba nel 1967, laureato in Scienze Politiche, ha conseguito un
PhD in Letterature Ispanoamericane presso la University of California
Berkeley e recentemente ha vinto la prestigiosa Guggenheim Fellowship,
che conferma la sua statura di talentuoso scrittore. Ha pubblicato i
romanzi: Dias de papel (1992), Rio fugitivo (1998), Sueños Digitales (2001), El Delirio del Turing (2003) e Palacio Quemado (2006) Norte (2011), Iris (2014) e La materia del deseo (2002) (in Italia sempre per Fazi, nel 2008: La materia del desiderio). I suoi libri di racconti sono Las mascaras de la nada (1990), Desapareciones (1994) Amores imperfectos (1998) . Insieme ad Alberto Fuguet ha curato un’antologia di racconti di giovani scrittori latinoamericani residenti negli USA (Se habla español, 2002). Ha curato, insieme ad Gustavo Faveròn Patrian la raccolta di scritti su Roberto Bolano: Bolano salvaje (in italiano Bolano selvaggio, Senzapatria edizioni) Vive nello Stato di New York e insegna alla Cornell University.
Etichette:
Edmundo Paz Soldàn,
Fazi,
Libros,
Rìo Fugitivo
domenica 22 febbraio 2015
Il fuggiasco di Xiamen, di Oliver August, Adelphi editore
Il titolo originale è Inside the Red Mansion, che non ha nulla a che vedere con quello italiano, Il fuggiasco di Xiamen. Il sogno della Residenza Rossa è uno dei quattro romanzi considerati i grandi classici della letteratura cinese, scritto da Cao Xuequin e pubblicato soltanto nel 1792, a trent'anni dalla morte del suo autore. Lai Changxing invece è il fuggiasco del titolo italiano, e Xiamen è la città dalla quale è fuggito, una città costiera (nella provincia di Fujian, di fronte all'isola di Taiwan) che è una delle zone che il governo centrale cinese ha destinato ad un esperimento di liberismo spinto. In pratica è una sorta di porto franco dove bene o male è concesso tutto, o quasi, in barba a Mao e ai suoi insegnamenti. La gente delle campagne vi si riversa a migliaia ogni giorno, tutti con la prospettiva di un futuro migliore, se non per sè, almeno per i propri figli. I palazzi sorgono da un giorno all'altro e l'aspetto dei quartieri viene stravolto di mese in mese. I grattacieli hanno nomi esotici (per noi, ovviamente), e crescono come funghi. Gli operai muoiono sulle impalcature grazie ad un'assenza quasi demenziale di standard di sicurezza, ma i milionari si moltiplicano a vista d'occhio ed hanno standard di vita extralusso. Chi è più in basso nella scala sociale, si lambicca il cervello per comprendere i segreti di chi ce l'ha fatta ed imitarli. Ognuno si dà da fare convinto che il proprio turno verso la ricchezza sia il prossimo. E Lai Changxing è uno che ce l'ha fatta, che il proprio turno l'ha strappato al destino e se l'è portato a casa e, nel giro di pochi decenni da campagnolo analfabeta diventa uno dei personaggi più in vista della nuova Cina e il "mammasantissima" di Xiamen. Tutti sanno chi è, tutti dicono di averlo incontrato almeno una volta, o di averlo visto, e tutti hanno degli aneddoti su di lui, leggende che lo ritraggono nei panni di munifico e onnipotente imprenditore, il cosiddetto Nuovo Che Avanza In Stile Cinese. Soldi, auto, belle donne, concubine, un palazzo, La Residenza Rossa appunto (nome che l'analfabeta Changxing mutua dal classico della letteratura), dove i funzionari di partito ed i militari possono dedicarsi ai piaceri della carne in santa pace, secondo il più classico dei luoghi comuni dei ricchi e potenti: le donne sono il miglior modo per ungere gli ingranaggi della burocrazia. Non si fanno affari senza donne di mezzo. Oliver August, giovane reporter mandato in Cina dal Times perchè è l'unico che si fa avanti per ricoprire il ruolo di inviato nel paese dove non tramonta mai il sole, e non perchè affascinato dalla cultura orientale nè da altro, ma semplicemente per prendere le distanze da una vita e da un lavoro che in quel momento stavano languendo in un brodo tiepido di tranquillità borghese che cominciava ad inquietarlo. August scopre presto Xiamen, vi si trasferisce per diversi mesi l'anno e vi s'immerge, immigrato come il resto della città. A Xiamen tutti sono immigrati da altri posti, di solito dalle campagne e da altre province, parlano altri dialetti, non conoscono la città e non appena si abituano all'aspetto del proprio quartiere questo cambia repentinamente. Tutti sono sradicati, tutti si reinventano. Xiamen è un (non) luogo dove tutto è possibile, dove ognuno può decidere chi essere e per quanto tempo. A Xiamen non si parla d'altro che di Lai Changxing, e August non può fare a meno che lasciarsi affascinare dalla sua figura che poco alla volta diventa la chiave privilegiata dell'autore per capire e raccontare la nuova Cina, l'accelerazione impressionante di una cultura che ha sempre fatto dell'impassibilità e dell'immobilismo una virtù e che, con il comunismo del Grande Padre Mao, si era disegnata come una struttura perfetta dove tutto doveva funzionare e quindi funzionava, a prescindere da quello che realmente accadeva, al suo interno ed al di fuori di essa. Morto Mao, Deng Xiaoping, lancia il proprio paese verso il futuro e, considerata la risposta che ne riceve, viene da pensare che il paese non aspettasse altro. Come se avesse trattenuto il fiato per tutta l'epoca maoista e all'improvviso, finalmente, potesse immettere aria nuova nei polomoni per mettersi a correre. La ricerca di Lai Changxing da parte dell'autore diventa così il tentativo del lettore di capire un paese che in generale non conosce, o conosce ben poco, secondo pregiudizi ormai sorpassati, ma al contempo fa nascere una domanda (molte in realtà): Lai è un abile imprenditore spregiudicato (in un paese dove il capitalismo non esiste, se non come "capitalismo di stato") o un comune delinquente? E quel nucleo oscuro che è l'immensa macchina politica che dal Politburo scende giù fino agli oscuri burocrati di partito che ruolo svolge in questa storia e, più in generale, nell'attuale stagione politico-economica della Cina? Lai ha davvero corrotto tutti, dai militari ai funzionari, fino ai politici di primo rango del Politburo? E poteva fare altrimenti? Chi ha usato chi? Ed è vero che il governo, non solo lo ha tollerato, ma lo ha sostenuto fino al momento di entrare nel OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) per poi, non solo abbandonarlo, ma per finire col dargli la caccia fino a scovarlo in Canada? Cos'è la Cina oggi? Ha il volto di Lai Changxing o dei membri del Politburo? O forse delle maitresse dei nightclub, o magari delle adolescenti di campagna che si fanno quattro giorni di viaggio per arrivare a Xiamen e dedicare la loro giovane bellezza a soddisfare i desideri dei nuovi ricchi? Oggi, in Cina, chi conta realmente, i politici (che si arrangiano prendendo metodicamente mazzette per svolgere il proprio lavoro) o gli imprenditori (che le mazzette le allungano per poter far si che la macchina burocratica, lentamente, si muova e permetta loro di portare avanti i propri progetti)? Il governo sembra essere un'entità oscura che tutto sà, ma che più di tanto non s'intromette con la vita reale del proprio paese, un'entità che sopravvive a sè stessa essendo conscia che l'immenso paese che dovrebbe guidare ha bisogno di tempo per cambiare definitivamente senza collassare su sè stesso. Così, interviene di tanto in tanto, per far si che il caos della modernità non sia completamente senza una guida, ed è quando la mano del governo si muove che le regole non scritte all'improvviso cambiano e gli eroi d'un tratto diventano fuggiaschi.
Oliver August è corrispondente del Times e di numerose altre testate, fra cui The Wall Street Journal, Financial Times e The Washington Post. Dopo sette anni trascorsi in Cina, attualmente risiede e lavora in Medio Oriente. Il fuggiasco di Xiamen è apparso per la prima volta nel 2007
Oliver August è corrispondente del Times e di numerose altre testate, fra cui The Wall Street Journal, Financial Times e The Washington Post. Dopo sette anni trascorsi in Cina, attualmente risiede e lavora in Medio Oriente. Il fuggiasco di Xiamen è apparso per la prima volta nel 2007
Etichette:
Adelphi,
Il fuggiasco di Xiamen,
Libros,
Oliver August
sabato 7 febbraio 2015
Alla conquista di Lhasa, di Peter Hopkirk, Adelphi editore
Quando l'India era una colonia britannica gli Inglesi si presero un bello spavento. Causa di questo spavento era la Russia zarista (prima, e sovietica poi) che avanzava in Asia al ritmo di conquista di 150 chilometri al giorno. La paura (comprensibile) degli inglesi era che una volta occupata buona parte dell'Asia, o tutta, l'orso russo, si sarebbe avventato sul Tibet (formalmente sotto il controllo cinese) e da lì non avrebbe avuto nulla di meglio da fare, a quel punto, che gettarsi alla conquista dell'India. Detto in soldoni, questo è il Grande Gioco, lo sfondo storico del Kim di Ruyard Kipling e l'argomento dell'omonimo libro di Hopkirk, Il grande gioco appunto, in Italia edito da Adelphi, così come questo Alla conquista di Lhasa. Il Tibet è un'altipiano quasi irraggiungibile e incredibilmente inospitale che, dal settecento, aveva deciso di dare le spalle al mondo e di chiudersi in sè stesso. Questa chiusura, in buon parte subìta anche dai cinesi che, all'epoca, erano solo formalmente a comando del Tibet ma che in realtà se ne disinteressavano quanto più possibile, fu causa di un delizioso fraintendimento: ognuna delle potenze che considerava il Tibet come strategico riteneva che il Tibet stesso avesse stretto alleanze con una delle altre potenze concorrenti: Inghilterra, Russia e Cina. Da qui la necessità inderogabile di giungere nella capitale, Lhasa, la Città proibita, e farsi un'idea di come stavano realmente le cose. Il problema era che il Tibet era impermeabile al resto del mondo. Non accettava stranieri, in special modo occidentali. In primo luogo il territorio era la prima e principale barriera che respingeva chiunque volesse penetrare in Tibet senza essere preparato ad affrontare una sorta di inferno naturale, e in seguito, chi, armato di coraggio e fibra fuori del comune, riusciva a superare gli ostacoli del territorio e del clima, si trovava al cospetto dei rappresentanti del governo tibetano che - terrorizzati dall'idea che una potenza straniera potesse non solo invaderli, ma anche sostituire il loro credo religioso (che era anche credo politico: i lama avevano autorità spirituale e temporale, ed erano loro, con a capo il Dalai Lama, a governare politicamente il Tibet) con una religione aliena alla loro realtà - gli si paravano di fronte lasciando loro la scelta se tornare da dove erano venuti o venire arrestati e sottoposti all'implacabile giudizio che attendeva gli stranieri illegalmente intrufolatisi nel paese. Le pene, a detta del vero, erano piuttosto pesanti e rispecchiavano più il medioevo nel quale il Tibet si ostinava a vivere che non l'immagine spirituale e pacifista che ne abbiamo oggi (bruciare gli occhi, spezzare le ossa, venire gettati in celle malsane a vita, venir chiusi, legati mani e piedi in sacchi e gettati vivi nei fiumi, erano tutte applicazioni pratiche della legge che il Dalai Lama, il Dio-Re amatissimo in Tibet, rappresentava e gestiva). Detto questo, Alla conquista di Lhasa è il resoconto storicamente accurato e narrativamente appassionante dei ripetuti tentativi da parte degli occidentali (non solo inglesi per la verità) di raggiungere in segreto la Città proibita del Tibet, la mitica Lhasa. Scopriremo, leggendolo, un paese che pare essere un universo a parte, sporco, violento e inspiegabilmente allegro, per molti versi assurdo, dove i Dalai Lama che morivano avvelenati prima di raggiungere la maggiore età (per poter così governare) erano la maggioranza, dove i Lama, come rappresentanti di ogni classe di governo al mondo erano anche (non solo ovviamente) dei donnaioli privilegiati e spesso governanti intransigenti e bellicosi; un paese in cima al mondo che al mondo chiedeva semplicemente di essere lasciato in pace a vivere il medioevo che si era scelto e che, per cause geopolitiche che per molto tempo neppure riuscì a comprendere, al contrario si trovò a difendere con le unghie e con i denti il proprio assurdo isolamento, fino all'inevitabile capitolazione. Conosceremo personaggi tanto eroici quanto assurdi, indiani al soldo del governo inglese e avventurieri di ogni parte del globo, uomini e donne, bambini addirittura, folli e sognatori, cattolici ferventi in cerca di una terra da evangelizzare, medici, militari, aviatori e chi più ne ha più ne metta. Da un certo momento in poi il semplice dato geopolitico (capire cosa diavolo stava succedendo a Lhasa, e con chi si fosse schierato il Tibet: per la cronaca, con nessuno) passò in secondo piano e, semplicemente nacque "la febbre della conquista di Lhasa". Dal momento che nessun occidentale poteva metterci piede, e nessuno ve lo aveva mai messo fino ad allora, buona parte delle teste calde dell'occidente disposte a rischiare la vita o peggio, decisero che l'obiettivo stesso della loro vita era esattamente quello: essere ricordati come i primi ad entrare a Lhasa. Ecco, questo è un libro folle. E magnifico. Pur essendo un saggio storico, si legge come il più intrigante dei libri d'avventura, non si lascia mollare. Vorrei star qui a discettare di questioni politiche, storiche, strategiche e magari pure religiose e antropologiche (tutti aspetti che il libro tocca) e spiegarvi perchè questo libro sia una lettura imprescindibile per ogni intellettuale che si rispetti (e sarebbe anche un'osservazione giusta da parte mia), ma la verità è che è un libro bellissimo, interessante e, a tratti, divertente (lo stile ironico e distaccato dell'inglese Hopkirk in certi casi è impagabile), come un'istantanea della follia umana. E la follia è tragica e spassosa al contempo.
Peter Hopkirk: (15 Dicembre 1930 - 22 Agosto 2014) è stato un giornalista e saggista inglese.
Ha viaggiato per molti anni in molti posti, tra cui Russia, Asia Centrale, il Caucaso, India e Pakistan, Iran e Turchia orientale. Questi paesi sono il panorama dei suoi 6 libri pubblicati.
Prima di diventare autore a tempo pieno è stato reporter per la Independent Television News, corrispondente da New York per il Daily Express ed in seguito ha lavorato per quasi vent'anni a The Times, cinque come capo reporter e poi come specialista del Medio ed Estremo Oriente.
Peter Hopkirk: (15 Dicembre 1930 - 22 Agosto 2014) è stato un giornalista e saggista inglese.
Ha viaggiato per molti anni in molti posti, tra cui Russia, Asia Centrale, il Caucaso, India e Pakistan, Iran e Turchia orientale. Questi paesi sono il panorama dei suoi 6 libri pubblicati.
Prima di diventare autore a tempo pieno è stato reporter per la Independent Television News, corrispondente da New York per il Daily Express ed in seguito ha lavorato per quasi vent'anni a The Times, cinque come capo reporter e poi come specialista del Medio ed Estremo Oriente.
Etichette:
Adelphi,
Alla conquista di Lhasa,
Libros,
Peter Hopkirk
domenica 18 gennaio 2015
Come diventai Monaca, di Cesar Aira, Feltrinelli editore
Quello che posso dire è che alla fine il(-la) protagonista non diventa monaca. Il titolo forse è un gioco di parole che può capire solo chi conosce il vesre, la parlata popolare del Rio de la Plata: per chi, come me, non lo conosce, c'è la nota esplicativa del traduttore a fine romanzoa spiegare il probabile gioco di parole del titolo, ma sconsiglio di leggerla se non a termine del libro, per non guastarvi il finale. La storia: si tratta di un anno, il sesto, nella vita di Cesar, il protagonista e narratore, un bambino che parla di sè al femminile, e di tutto ciò che durante questo suo sesto anno di vita sulla terra gli è capitato tra capo e collo (così direbbe Salinger, credo). Il romanzo, ambientato in Argentina tra Pringles e Rosario, si apre con un'ondata di avvelenamenti da cibo e termina con una serie di omicidi di bambini, rapiti, violentati e abbandonati nei campi da presunti vampiri. Il padre di Cesar lo accompagna a mangiare un gelato: è la prima volta per Cesar che fino ad allora non ne ha mai assaggiato uno e non sa cosa aspettarsi. Certo non il sapore terribile che si ritrova in bocca alla prima cucchiaiata. Il padre si inalbera, si sente offeso, si era immaginato di vedere la gioia e lo stupore affiorare sul volto del figlio, e non riesce a credere alla sua ottusità. La prende come una questione personale: ha messo al mondo un figlio talmente strambo (parla di sè, essendo maschio, come se fosse una femmina) da essere l'unico bambino al mondo incapace di apprezzare il gelato. S'infuria, ma quando alla fine -non per verificare la veridicità delle giustificazioni del figlio (cioè che il gelato è sì freddo, ma ha un sapore nauseante) bensì per dimostrargli di essere nel torto - assaggia a sua volta la coppetta di gelato alla fragola, la sua rabbia diviene cieca e si rivolge selvaggiamente contro il gelataio. Il gelato, in effetti, era disgustoso. Andato a male, o peggio. Cesar aveva ragione. Finisce con il padre che, in un accesso di folle rabbia, uccide il gelataio e finisce in carcere, condannato ad otto anni (forse così pochi perchè in fondo tutti i torti non li aveva), e con Cesar in ospedale curato per avvelenamento (in quel periodo, come detto, l'Argentina era vittima di una demenziale ondata di avvelenamenti alimentari). Da qui prende il via questo breve romanzo del poliedrico (nonchè prolifico) scrittore argentino Cesar Aira. Le vie (narrative) attraverso cui si snoda il romanzo, pur non essendo confuse, ci confondono. I morti ci sono, e da subito, c'è in sottofondo la follia collettiva degli avvelenamenti e la violenza cieca e mostruosa delle morti dei bambini (la faccenda misteriosa dei "vampiri"), ma non è un romanzo noir nè tantomeno horror. L'occhio del narratore, cioè Cesar, non percepisce la brutalità e l'insensatezza del mondo che lo circonda come tale o, per meglio dire, non dà a tali caratteristiche il peso ed il giudizio che ci potremmo aspettare; il suo narrare, per quanto sia testimone e protagonista di eventi per lo più incredibili, è quasi esclusivamente un raccontare veicolato al proprio interno. In questo senso si può intendere come un romanzo, seppur strampalato, di formazione o un racconto (non tanto per quanto) d'infanzia. Ma tutto il romanzo gioca in un territorio fuori dagli schemi: dalla lunghezza (romanzo breve o racconto lungo?), all'identità sessuale del protagonista (maschio o femmina?), al presunto o effettivo biografismo della narrazione (Cesar è Cesar Aira l'autore del libro o no?), al finale che chiude una storia in maniera sorprendente e spiazzante (senza però lasciare l'amaro dubbio che l'autore si sia inventato in fretta e furia un finale perchè stufo della sua stessa storia, come spesso avviene). Si tratta piuttosto di una biografia dell'anima, o qualcosa del genere. Mi spiego: non penso che Cesar Aira (l'autore) si sia avvelenato mangiando del gelato alla fragola all'età di sei anni, nè tantomeno che suo padre abbia ucciso a mani nude il gelataio, nè il resto degli accadimenti narrati ritengo siano nè verosimili nè comunque, anche qualora lo fossero, attribuibili alla vita dell'autore. I pensieri del protagonista si. Lo stupore quasi estatico di fronte allo scorrere incomprensibile del mondo, la tendenza (al limite - o oltre il limite - del patologico) all'invenzione, alla manipolazione del reale per poterlo in qualche maniera maneggiare con una grazia infantile che ogni volta rinnova il miracolo della creazione. Costruirsi un mondo su misura partendo da quello imperfetto e a tratti terribile che ci tocca calpestare ogni dannato (e/o benedetto) giorno, sostituire storie ed illusioni a quanto ci scorre di fronte agli occhi per poter prendere le distanze dal mondo quel tanto che basta per riuscire a viverci. Più in generale, questo Come diventai monaca può (e, a mio avviso, deve) essere considerato una biografia interiore dello scrittore (o, più in generale, dell'artista), intendendo lo scrittore con la S maiuscola, qualsiasi scrittore (qualsiasi artista). La maestria di Aira sta nel fottersene altamente della veridicità dei fatti che descrive e riportare con attenzione maniacale e (anatomo-)patologica la realtà assoluta di ciò che il suo protagonista prova, di come lo prova, di come lo interpreta e di come lo risputa al mondo modellato, cambiato, distorto, abbellito. Nella scrittura di Aira emerge lo stupore-non stupore della realtà vista dallo spazio quando per spazio intendo quello interiore di Cesar, che però, in un certo senso è uno spazio siderale, che dista dal mondo reale distanze infinite, pur rimanendo paradossalmente inner.
Quando gustare un gelato alla fragola può creare interi universi narrativi (forse brevi, se consideriamo il numero di pagine un metro di misura, ma certamente ricchissimi).
Cesar Aira: scrittore e traduttore argentino (n. Coronel Pringles, Buenos Aires, 1949). Annoverato tra i più influenti autori latinoamericani, ha all’attivo più di sessanta pubblicazioni; tra queste racconti, romanzi e testi teatrali, ma anche numerosi saggi e articoli di critica letteraria. Oltre a essere un prolifico traduttore, A. è considerato un esperto dell’opera di O. Lamborghini e A. Pizarnik (suoi connazionali) e dei grandi poeti del simbolismo francese (fra tutti S. Mallarmé). Tra i lavori più recenti si ricordano Las aventuras de Barbaverde (2008), El error (2010) e El marmol (Il marmo, Sur edizioni: 2014) (2011); gran parte della sua produzione è disponibile per il mercato italiano. Allego qui un'intervista a Cesar Aira apparsa sul Blog di Suredizioni e, sempre sul medesimo blog, l'elenco di pagine che trattano di Aira: qui.
Quando gustare un gelato alla fragola può creare interi universi narrativi (forse brevi, se consideriamo il numero di pagine un metro di misura, ma certamente ricchissimi).
Cesar Aira: scrittore e traduttore argentino (n. Coronel Pringles, Buenos Aires, 1949). Annoverato tra i più influenti autori latinoamericani, ha all’attivo più di sessanta pubblicazioni; tra queste racconti, romanzi e testi teatrali, ma anche numerosi saggi e articoli di critica letteraria. Oltre a essere un prolifico traduttore, A. è considerato un esperto dell’opera di O. Lamborghini e A. Pizarnik (suoi connazionali) e dei grandi poeti del simbolismo francese (fra tutti S. Mallarmé). Tra i lavori più recenti si ricordano Las aventuras de Barbaverde (2008), El error (2010) e El marmol (Il marmo, Sur edizioni: 2014) (2011); gran parte della sua produzione è disponibile per il mercato italiano. Allego qui un'intervista a Cesar Aira apparsa sul Blog di Suredizioni e, sempre sul medesimo blog, l'elenco di pagine che trattano di Aira: qui.
Etichette:
Cesar Aira,
Come diventai monaca,
Feltrinelli editore,
Libros
giovedì 11 dicembre 2014
Il rumore delle cose che cadono, di Juan Gabriel Vasquez, Ponte alle Grazie editore
Se, come ho avuto modo di definirla, la letteratura è l'arte di tirarla per le lunghe, allora questo Il rumore delle cose che cadono (in spagnolo: El ruido de las cosas al caer) è certamente letteratura. Per fare un esempio: il romanzo comincia nel 2009 con un ippopotamo di una tonnellata e mezzo di peso che viene abbattuto (un incipit straordinario, a mio modesto parere). Il malcapitato ippopotamo era scappato due anni e mezzo prima dal giardino zoologico de l'Hacienda Napoles, la tenuta nella valle del fiume Magdalena (nel dipartimento di Antioquia, Colombia) di proprietà di Pablo Escobar. Più o meno a fine romanzo, i protagonisti torneranno, anni dopo la loro infanzia, ormai adulti, all'Hacienda Napoles, e sarà un cerchio che si chiude, in un certo senso, dopo un lungo viaggio. Noi, invece, mettiamo ordine: Antonio Yammara è un professore universitario che scivola sulla sua vita con un certa elegante leggerezza, passando da una giovane amante ad un'altra e trascorrendo parte del suo tempo libero a giocare a biliardo: Ricardo Laverde no. Ricardo Laverde si limita a comparire da un giorno all'altro nella sala biliardi ed a giocare qualche partita. Educato, elegante, rispettoso: porta con sè un segreto. E' un segreto che dovrebbe rimanere tale ma che in realtà segreto non lo è per nessuno. A Bogotà, le voci girano in fretta e non è possibile mantenerle sotto controllo. Ricardo Laverde, educato, elegante, rispettoso, a tratti quasi timido, è da poco uscito dal carcere, il perchè ci fosse finito, quello sì rimane un segreto. Laverde muore vittima di un attentato e in quel medesimo attentato rimane ferito Antonio Yammara. Da quel momento la vita di Yammara, cambia. La paura della violenza immotivata ed improvvisa, della morte che può colpire chiunque ed in qualsiasi momento diviene una tragica ossessione per il giovane professore, serrandolo in una invisibile prigione di paure che lo riporta ai terribili anni ottanta, gli anni in cui, giovane, nonostante molti emigrassero, era stato tra coloro che erano rimasti a Bogotà, ad assistere alla sanguinosa ascesa di Pablo Escobar (non per niente già citato nella prima pagina del libro, assieme all'ippopotamo), spettatore di una guerra mai ufficialmente dichiarata nella quale i morti si contavano col pallottoliere e che, spesso, erano ignari passanti, cittadini qualunque, donne, bambini, lavoratori, viaggiatori, tutti sacrificati con straordinaria leggerezza in attentati che dovevano colpire una sola persona (a volte, senza neppure riuscirvi) ma che immancabilmente causavano vere e proprie carneficine.Va da sè che per Yammara il biliardo è un argomento chiuso (per Laverde pure, e non solo quello). L'unico modo che sarà dato a Yammara (per certi versi anche suo malgrado) di affrontare le sue paure e tornare ad una vita normale, sarà immergersi in una detection che lo porterà a scoprire chi era Ricardo Laverde e perchè diavolo era finito in galera per vent'anni. In questa parentesi temporale - che poi è la vera polpa del libro, e che è la sua letterarietà, il tirarla per le lunghe appunto - il lettore è condotto non solo lungo le tappe della storia di Laverde (della sua famiglia, di quella che sarà sua moglie, del suo essere pilota di aerei, ecc.) ma anche (e soprattutto) lungo la via crucis della storia della Colombia attuale, da paese povero, terra bisognosa dell'aiuto dei Peace corps americani, a regno della droga, impero comandato sfacciatamente da un uomo solo (Pablo Escobar appunto), un narcotrafficante che diviene nell'arco di pochi anni l'uomo più potente della Colombia, tanto da potersi sostituire proterviamente allo stesso Stato. I gringos, che sono la domanda, che chiedono droga (inizialmmente solo marijuana, ma sarà per poco), e i colombiani, che la soddisfano questa domanda, tutti i colombiani, da Escobar e i suoi scagnozzi, ai contadini che convertono i campi alla coltura delle piante di marijuana, ai politici che si lasciano felicemente corrompere, fino al cittadino comune che preferisce far finta di niente, che accetta il ruolo di vittima pur di non alzare la testa e guardare in faccia la realtà. E il giardino zoologico che rimane come simbolo non solo, o non tanto, dell'ascesa e della caduta del regno di terrore di Escobar (che strano, ora che ci bado suona come il nome di una cialda per caffè, o qualcosa di simile) quanto del disfacimento in cui rimane intrappolata la Colombia intera. E' come se tutta la colombia (e quindi tutti i colombiani) fosse quel pugno di animali ormai abbandonati ed affamati nei recinti dell'Hacienda Napoles, senza speranza e in attesa che qualcuno venga a dar loro il colpo di grazia. Una tonnellata e mezzo, tanto di ippopotamo quanto di paese, che cade e crolla morto a terra, quella stessa tonnellata e mezzo di ippopotamo/paese fuggita dal giardino zoologico di Escobar in cerca di... speranza immagino. Vasquez parte da due vite che si incrociano e racconta la storia recente del suo paese, tirandola per le lunghe, per nostra fortuna.
Juan Gabriel Vásquez è nato a Bogotà nel 1973. Scrittore sudamericano di primissimo piano, tradotto in sedici lingue, ha conseguito un grande successo internazionale di critica e di pubblico con i suoi romanzi. Gli informatori (Ponte alle Grazie, 2009) è stato scelto come uno dei romanzi colombiani più importanti degli ultimi venticinque anni dalla rivista “Semanal”, è arrivato finalista dell’Independent Foreign Fiction Prize e ha attirato gli elogi di autori come Mario Vargas Llosa e John Banville. Storia segreta del Costaguana (Ponte alle Grazie, 2008), magnifico omaggio alla storia colombiana e all’opera di Joseph Conrad, si è aggiudicato il Premio Qwerty a Barcellona e il Premio Fundación Libros & Letras a Bogotà. Il rumore delle cose che cadono (Ponte alle Grazie, 2012), oltre agli elogi di scrittori del calibro di Edmund White e Jonathan Franzen. Si è aggiudicato il Premio Alfaguara 2011, il English Pen Award 2012 e il Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze 2013. Vásquez ha inoltre vinto due volte il Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar e nel 2012 gli è stato assegnato il premio francese Roger Caillois per l’insieme dell’opera. Feltrinelli ha pubblicato Le reputazioni (2014).
Juan Gabriel Vásquez è nato a Bogotà nel 1973. Scrittore sudamericano di primissimo piano, tradotto in sedici lingue, ha conseguito un grande successo internazionale di critica e di pubblico con i suoi romanzi. Gli informatori (Ponte alle Grazie, 2009) è stato scelto come uno dei romanzi colombiani più importanti degli ultimi venticinque anni dalla rivista “Semanal”, è arrivato finalista dell’Independent Foreign Fiction Prize e ha attirato gli elogi di autori come Mario Vargas Llosa e John Banville. Storia segreta del Costaguana (Ponte alle Grazie, 2008), magnifico omaggio alla storia colombiana e all’opera di Joseph Conrad, si è aggiudicato il Premio Qwerty a Barcellona e il Premio Fundación Libros & Letras a Bogotà. Il rumore delle cose che cadono (Ponte alle Grazie, 2012), oltre agli elogi di scrittori del calibro di Edmund White e Jonathan Franzen. Si è aggiudicato il Premio Alfaguara 2011, il English Pen Award 2012 e il Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze 2013. Vásquez ha inoltre vinto due volte il Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar e nel 2012 gli è stato assegnato il premio francese Roger Caillois per l’insieme dell’opera. Feltrinelli ha pubblicato Le reputazioni (2014).
domenica 30 novembre 2014
Il ragazzo selvaggio, di T.C. Boyle, Feltrinelli editore
Nel 1797, nel sud della Francia, nella zona dell'Aveyron, i contadini avvistano ripetutamente quello che sarà ribattezzato Victor ma che in quel momento non è altro che uno scherzo della natura, un mostro. Forse, un animale di una specie sconosciuta. T.C. Boyle ci accompagna lungo tutto l'arco dell'avventura di Victor, dal momento della sua cattura fino a quello della sua morte, a quarant'anni. Il ragazzo, perchè di essere umano si tratta, è e rimarra per il resto della sua vita più basso della media, non è in grado di articolare parola, si muove su quattro zampe come gli animali, incrostato di terra e sporcizia pare essere, al di là del suo aspetto, in tutto e per tutto un animale. Il suo unico interesse (quantomeno fino al raggiungimento dell'adolescenza ed allo sbocciare degli istinti sessuali) pare essere il cibo, e tale rimane anche quando non rappresenta più un impellente bisogno da soddisfare andando a caccia di piccoli animali o nutrendosi di tuberi e frutti (dal momento della sua cattura ormai il cibo gli viene offerto, cotto e cucinato, in tavola ogni giorno). Il rumore (mediatico, diremmo oggi) derivante dalla sua cattura, nella Francia dell'epoca, è enorme: tutti vogliono vedere il Selvaggio (così verrà ribattezzato dalla pubblica opinione), aspettandosi un fenomeno da baraccone pronto a sgranare gli occhi di fronte alle meraviglie della civiltà. La società, insomma, considera Victor uno specchio nel quale rimirare la propria superiorità a qualsiasi altro stato di natura. Nel momento in cui questo non avviene (Victor pare totalmente impermeabile agli splendori di Parigi: si limita a cullarsi sui talloni, ad addentare tutto ciò che può, senza fare eccezioni di buongusto nè di convenienza sociale, a fissare il vuoto ed a tentare la fuga verso il mondo dei boschi da cui proveniva), la società perde ogni interesse nei suoi confronti. Solo due uomini di scienza continuano ad interessarsi a lui: Pinel ed Itard. Pinel, direttore dell'istituto per sordomuti, si convince presto che il ragazzo è affetto da idiotismo ed è irrecuperabile, mentre Itard ritiene di poterlo educare e riportare nell'alveo della civiltà. Itard spenderà cinque anni della sua vita in sforzi titanici e pressochè vani per inisegnare al ragazzo selvaggio ad articolare parola, nonchè i rudimenti del comportamento ed a rendersi utile ritagliandoli un ruolo nella società. Tutto ciò che riuscirà ad ottenere sarà fargli pronunciare un unico verso e insegnargli ad apparecchiare tavola e a spaccare la legna. Questo è quanto "la civiltà" riesce ad ottenere, a costo di sforzi enormi, da Victor e dalla sua natura selvatica. Alla fine, Itard e lo stato francese che aveva sovvenzionato i suoi tentativi ammetteranno la loro sconfitta e lasceranno Victor alle cure della governante madame Guerin, l'unica che ha avuto, nella sua semplicità, la capacità di amare il ragazzo per quello che è, senza pretendere da lui sforzi improbi per raggiunere obiettivi che, evidentemente, non erano alla sua portata. T.C. Boyle compone un libro snello e gradevole che con una lievità apparente scandaglia una vicenda reale e simbolica allo stesso tempo che ci consegna un ritratto dell'esistenza umana quale esperienza tanto intensa quanto inutile. E' il libro della frustrazione. Il solido Pinel probabilmente aveva ragione: il ragazzo era stato abbandonato (recava una cicatrice da lama sul collo, probabile tentativo di sgozzamento da parte di chi voleva liberarsi di lui) in quanto sordomuto o affetto da qualche forma di deficenza e il suo recupero non poteva avvenire proprio per questo motivo: un muro invalicabile. Pinel sostenne fino all'ultimo che era stato il suo crescere lontano dal consesso umano e dalle sue regole di civiltà a ridurlo irrimediabilmente ad uno stato animale. Rousseau e il suo mito del buon selvaggio: confutazioni e controconfutazioni (tutte tentate, nessuna dimostrata nè dimostrabile). Quanto rimane del senso di frustrazione è una parentesi di stupore per la pervicacia con la quale l'essere umano rimane aggrappato ad un'esistenza che pare non aver senso alcuno se non il trascorrere del tempo: Victor, bambino abbandonato, probabilmente vittima di un tentato omicidio, quasi sicuramente affetto da qualche forma di handicap mentale, che riesce a sopravvivere prima nel mondo selvatico dello stato naturale e poi, in un secondo momento, al momento della sua cattura - cosa non meno facile della prima -, all'impatto con la civiltà e la sua smania di civilizzarlo (l'unica che si limiterà ad accettarlo veramente sarà madame Guerin, tutti gli altri esseri umani cercheranno di ottenere qualcosa da lui, fosse anche, apparentemente, per il suo bene). E Itard, che nonostante i risultati dei suoi sforzi educativi, continua a credere di poter riportare Victor a quello che ritiene essere il suo posto nel mondo (almeno fino a quando non interviene lo stato a porre fine alle sue fatiche pedagogiche).
T.C. Boyle (1948) è uno scrittore statunitense. Autore di numerosi libri tra romanzi e raccolte di racconti, è tradotto in tutto il mondo. Le sue storie sono apparse su riviste prestigiose quali “The New Yorker”, “Esquire”, “Playboy”, “The Paris Review”, “Granta” e “McSweeney’s”. In Italia sono stati pubblicati América (1997), Se il fiume fosse whisky (2001), Amico della terra (2001), Doctor Sex (2004), Infanticidi (2006) e Identità rubate (2008), Le donne (2009), Il ragazzo selvaggio (2012) e L'isola dei topi (2014).
T.C. Boyle (1948) è uno scrittore statunitense. Autore di numerosi libri tra romanzi e raccolte di racconti, è tradotto in tutto il mondo. Le sue storie sono apparse su riviste prestigiose quali “The New Yorker”, “Esquire”, “Playboy”, “The Paris Review”, “Granta” e “McSweeney’s”. In Italia sono stati pubblicati América (1997), Se il fiume fosse whisky (2001), Amico della terra (2001), Doctor Sex (2004), Infanticidi (2006) e Identità rubate (2008), Le donne (2009), Il ragazzo selvaggio (2012) e L'isola dei topi (2014).
Etichette:
Feltrinelli editore,
Il ragazzo selvaggio,
Libros,
T.C.Boyle
giovedì 27 novembre 2014
Ballata per mia madre, di Juliàn Herbert, Gran Vìa edizioni
La cavalcata un po' svitata e un po' disperata di una vita, di una donna, di una prostituta (anche se, a suo dire, di classe) e il finale, soprattutto il finale, la bellezza che svapora, il corpo che si svuota, si secca attorno alle ossa, si lascia erodere dalla malattia e lo sguardo (che poi è scrittura) di un figlio che la segue, l'accompagna, e la odia nella stessa misura in cui la ama. Un distacco lento ed impietoso di una madre (a sua volta
figlia e vittima di un Messico eccessivo e violento) dal figlio e, soprattutto, di un figlio dalla madre. Questo, è un libro raro (non so se sia unico - in un certo senso dovrebbero esserlo tutti, e non lo sono - ma sicuramente raro lo è), poetico nel suo non esserlo affatto, narrato con una scrittura (che poi è sguardo) fantastica, fantasiosa e al contempo a tal punto precisa da rivelarsi, a tratti, chirurgica. Immagino sia biografia, o fantabiografia, o qualcosa del genere, ma onestamente non me ne frega niente, non mi ci metto neppure a cercare interviste in spagnolo per capire se si tratti della storia della morte della madre dello scrittore, semplicemente perchè non è importante. Il fatto essenziale è che, quando lo si legge, ci si convince che si tratta di un racconto biografico, e questo è quanto. Se di biografia si tratta, è impietosa, non maschera, non abbellisce, non trasfigura, non romanza, dice pane al pane e vino al vino, la mamma è la mamma, ma è anche una prostituta, una donna perennemente bambina in cerca di qualcosa in giro per il paese, di città in città, o forse in fuga dalla sua stessa infanzia ( e da chissà cos'altro, un insetto che cerca di fuggire sbattendo contro le pareti di vetro del bicchiere che lo intrappola. La struttura non è quella di un'indagine, non andiamo a ritroso alla ricerca di quel nucleo centrale che è stata la madre dell'autore, non cerchiamo come rabdomanti un episodio che l'ha trasformata nella puttana che era, non è questo il libro, e non vuole esserlo. Non importa sapere il perchè, il perchè dei tanti figli e degli altrettanti padri di quei figli, non importa tornare al momento in cui la ragazza che fu decise di mettere piede in un bordello, e il perchè, il quando, il dove, il nome del bordello, le luci soffuse che proiettavano o non proiettavano luci equivoche su un pavimento coperto di cicche e gusci di noccioline. In realtà non interessa nulla di tutto questo a Herbert. Il centro del libro è l'ossessione dell'autore di dire tutto, tutto raccontare, di non lasciare nulla di non detto, di non eviscerato: i suoi matrimoni, le storie passate e quella presente, i suoi figli già nati e quello in arrivo, la sua dipendenza da cocaina, il suo essere a tutti gli effetti un figlio di puttana, di esserlo sempre stato e di averlo marchiato sulla pelle e fin nell'anima, se fosse certo al cento per cento di averne una, il suo essere scrittore, il suo essere un pessimo padre, e l'aver patito la fame, l'essere stato un pacco sballottato di città in città a seguito di sua madre e dei suoi amori, delle sue follie, e dei suoi bordelli, le sue fantasie e le sue paure, la paura di passare da essere figlio di puttana ad essere puttana lui stesso. Dire tutto, trasferire tutto su carta, renderlo evidente, vivo, vero: il suo ultimo amore, la gravidanza della sua compagna, il figlio in arrivo, l'ennesimo ("n", in questo caso, è da intendersi uguale a tre), l'ospedale e le notti trascorse seduto accanto alla madre a scrivere di sè stesso seduto, in ospedale, a scrivere accanto alla madre. La scrittura (che poi è lo sguardo), l'ossessione per la scrittura, per lo stile, l'amore per le parole che, non viene mai detto, ma si percepisce che sono la mano che l'ha salvato: salvato da una vita anonima, forse misera, salvato dalla follia latente di essere il figlio di sua madre, che forse l'hanno salvato da un tentativo di suicidio e che, ora, in presa diretta, lo salvano da uno tsunami di dolore e risentimento, di amore ed incomprensione che accompagna la morte della madre. La scrittura è quella di un poeta (ed Hebert lo è), di un alchimista che gioca coi suoi amati elementi sapendo perfettamente l'effetto che otterrà ma che, al contempo, rimane egli stesso stupefatto dalle immagini e dalle sensazioni che gli escono dagli alambicchi, quasi in maniera involontaria. Non credo si possa spiegare un libro come questo, l'editrice mi aveva avvertito che si trattava di un libro particolare e, per fortuna, aveva ragione: è un'esperienza, da leggere, dura come un cubo di ghiaccio e perfettamente elegante, estemporanea ed unica come la struttura di un fiocco di neve.
Forse, a ben pensarci, questo libro è (anche) il tentativo impietoso di una famiglia che guarda sè stessa sgretolarsi e, forse, darsi un senso.
Spero ardentemente che Gran Vìa si premuri di pubblicare altro, ed al più presto, di Juliàn Herbert: è un autore da seguire, e da coltivare.
Juliàn Herbert è nato ad Acapulco nel 1971. Poeta, scrittore, musicista, è uno dei più poliedrici esponenti culturali del suo Paese. Ha al suo attivo diversi libri di poesie, saggi, il romanzo Un mundo infiel del 2004 e la raccolta di racconti Cocaìna (manual de usario) del 2006, di cui Granta Italia ha pubblicato nel 2013 un racconto nel numero dedicato al tema delle "Dipendenze". Ballata per mia madre ha vinto nel 2011 ilPremio Jaèn de Novela Inedita e l'anno successivo il Premio de Novela Elena Poniatowska, diventando uno dei romanzi rivelazione della recente letteratura messicana.
Forse, a ben pensarci, questo libro è (anche) il tentativo impietoso di una famiglia che guarda sè stessa sgretolarsi e, forse, darsi un senso.
Spero ardentemente che Gran Vìa si premuri di pubblicare altro, ed al più presto, di Juliàn Herbert: è un autore da seguire, e da coltivare.
Juliàn Herbert è nato ad Acapulco nel 1971. Poeta, scrittore, musicista, è uno dei più poliedrici esponenti culturali del suo Paese. Ha al suo attivo diversi libri di poesie, saggi, il romanzo Un mundo infiel del 2004 e la raccolta di racconti Cocaìna (manual de usario) del 2006, di cui Granta Italia ha pubblicato nel 2013 un racconto nel numero dedicato al tema delle "Dipendenze". Ballata per mia madre ha vinto nel 2011 ilPremio Jaèn de Novela Inedita e l'anno successivo il Premio de Novela Elena Poniatowska, diventando uno dei romanzi rivelazione della recente letteratura messicana.
Etichette:
Ballata per mia madre,
Gran Vìa edizioni,
Juliàn Herbert,
Libros
mercoledì 12 novembre 2014
Le notti di Reykjavik, di Arnaldur Indridason, Guanda editore
Gli slittamenti di luogo e tempo paiono essere diventati il marchio di fabbrica di Arnaldur Indridason (Le abitudini delle volpi, Cielo Nero e Sfida cruciale). Dopo aver fatto tornare Erlendur nei luoghi dove ha trascorso l'infanzia e perso il fratello in un tormenta di neve (Le abitudini delle volpi), alla ricerca quindi del proprio passato, nel tentativo, se non di farci pace, almeno di scendervi a compromessi, dopo aver descritto le indagini dei colleghi lasciati soli a Rekjavik in una sorta di montaggio parallelo (Cielo nero) ed essere tornato indietro nel tempo, fino ai giorni della storica sfida di scacchi tra Spassky e Bobb Fisher (Sfida cruciale), per seguire le indagini di una giovane marion Briem (il futuro capo di Erlendur), lo scrittore isalndese questa volta incasella un nuovo tassello del puzzle della vita del suo protagonista, riportandolo ai suoi esordi in polizia, quando, giovane agente della stradale, si trova ad indagare suo malgrado su due casi che, al principio, paiono non aver alcun punto in comune.Il giovane Erlendur è già taciturno, ombroso, riflessivo, profondamente segnato dalla tragedia della scomparsa del fratellino e da questa ossessionato nell'intimo. Comincia a collezionare e a leggere tutti i libri che gli riesce di trovare sulle scomparse avvenute in Islanda durante nevicate o altri eventi naturali, è totalmente impermeabile alla febbre americana che in quegli anni colpisce la sua terra, non possiede televisione, non ama gli hamburgher, non ama le pizze, e non si cura di avere un qualche cosa di anche vagamente simile ad una vita sociale. Tra una rissa da sedare, un incidente stradale e una violenza domestica (quasi tutte causate dall'alcool), Erlendur trova il tempo e la muta concentrazione (nonchè un certo compassato ardimento) di approfondire la morte, apparentemente per annegamento, di Hannibal, un senzatetto che aveva avuto modo di conoscere durante le sue ore di servizio. Hannibal annega vicino alla sua dimora (tubazioni del teleriscaldamento) in una quantità d'acqua che pare insufficente, al giovane agente, per causarne la morte. Da questo primo vago sospetto, oltrechè (se non soprattutto) dal suo interesse per la vicenda umana di Hannibal, Erlendur, si immerge nel sottobosco della vita sociale della capitale islandese, quello dei senza tetto, e lo sonda con il suo personale stile, quasi in punta di piedi, attento alle esistenze di coloro coi quali entra in contatto, ma al contempo inflessibile nella sua volontà di giungere ad una soluzione. La scomparsa di una donna che pare "una gioielleria ambulante" nello stesso week end in cui Hannibal muore, è un ulteriore stimolo per l'indagine di Erlendur. Inoltre, in questo ennesimo volume della saga che verte attorno, non solo alla figura di Erlendur ed alle sue indagini ma, quasi di pari passo, e sicuramente con pari dignità, anche alle sue vicende umane, assistiamo (quasi col fiato sospeso, pur sapendo perfettamente quali saranno gli sviluppi successivi) al primo incontro tra il protagonista e quella che sarà, prima sua moglie, poi la madre dei suoi figli, ed infine una ex moglie terribilmente rancorosa. E' un flashback inquietante e poetico che, ben sapendo che influsso avrà sulla vita di Erlendur (i due figli e le loro storie travagliate, la droga, le incomprensioni, la rabbia ed il nipote), ci stupisce per la levità con cui la vita ti pone di fronte a dei bivi che si riveleranno essenziali nel caratterizzare le nostre esistenze. A volte, paiono come soffi di vento gelido che giunge dolcemente dalle foreste innevate e silenziose e finiscono per rivelarsi vere e proprie tempeste nelle quali si perde tutto, non solo i fratelli, ma anche i propri figli e, infine, sè stessi.
L'ennesimo libro, perfettamente calibrato, di Indridason. Questo volume e arricchito dal commento di Camilleri che ci rende noto di aver già letto 5 libri della serie di Indridason. Con tutto il rispetto per Camilleri e per il suo Montalbano, i libri di Indridason li leggo a prescindere da qualsiasi consiglio.
Arnaldur Indriðason (Reykjavìk 28 Gennaio 1961)è uno scrittore islandese, noto particolarmente per i suoi romanzi polizieschi che hanno come protagonista il personaggio di Erlendur Sveinsson.
La traduttrice delle sue opere in italiano è Silvia Cosimini. Tutti i romanzi tradotti in italiano sono stati pubblicati dalla casa editrice Guanda.
Vive a Reykjavík, è sposato e ha tre figli. Dal 1981 al 1982 ha lavorato come giornalista al Morgunbladid. In seguito ha lavorato come giornalista indipendente e come critico cinematografico. Si è laureato in storia nel 1996 all'università islandese.
Ha iniziato la sua carriera di scrittore nel 1997 pubblicando il primo romanzo della serie dedicata al commissario Sveinsson. Ha vinto numerosi premi, fra i quali Glasnyckeln e Gold Dagger.
Su questo blog è già stato recensito il suo romanzo La signora in verde e Le abitudini delle volpi
L'ennesimo libro, perfettamente calibrato, di Indridason. Questo volume e arricchito dal commento di Camilleri che ci rende noto di aver già letto 5 libri della serie di Indridason. Con tutto il rispetto per Camilleri e per il suo Montalbano, i libri di Indridason li leggo a prescindere da qualsiasi consiglio.
Arnaldur Indriðason (Reykjavìk 28 Gennaio 1961)è uno scrittore islandese, noto particolarmente per i suoi romanzi polizieschi che hanno come protagonista il personaggio di Erlendur Sveinsson.
La traduttrice delle sue opere in italiano è Silvia Cosimini. Tutti i romanzi tradotti in italiano sono stati pubblicati dalla casa editrice Guanda.
Vive a Reykjavík, è sposato e ha tre figli. Dal 1981 al 1982 ha lavorato come giornalista al Morgunbladid. In seguito ha lavorato come giornalista indipendente e come critico cinematografico. Si è laureato in storia nel 1996 all'università islandese.
Ha iniziato la sua carriera di scrittore nel 1997 pubblicando il primo romanzo della serie dedicata al commissario Sveinsson. Ha vinto numerosi premi, fra i quali Glasnyckeln e Gold Dagger.
Su questo blog è già stato recensito il suo romanzo La signora in verde e Le abitudini delle volpi
Etichette:
Arnaldur Indridason,
Guanda editore,
Le notti di Rekjavik,
Libros
giovedì 21 agosto 2014
Americani, di John Jeremiah Sullivan, Sellerio editore
Premesso che il titolo "Americani" (titolo originale "Pulphead") e l'immagine di copertina che riporta la faccia di Michael Jackson non invogliano un granchè all'acquisto del libro, in realtà, se doveste decidervi a superare lo scoglio di cui sopra e puntare i vostri sudati risparmi su questa raccolta di articoli di John Jeremiah Sullivan, l'avreste indovinata. Cominciamo: quattro pezzi e mezzo sono di taglio musicale, più un tot (sette) di altri che svariano dalla fine del mondo per mano di una sinistra quanto comprensibile alleanza tra diverse specie animali, ad una terrificante gita famigliare a Disneyworld (comprensiva di excursus su certi aspetti poco edificanti della sua nascita e della mentalità del vecchio zio Walt), al vivere in una casa che è al contempo il set cinematografico di una famosissima una serie tv per adolescenti. E poi: una passeggiata nei luoghi devastati dalla precedente passeggiata di Katrina (l'uragano), una ricognizione nel mondo dei real tv americani (e nelle menti di coloro che li vivono - non che vi partecipano, ma che proprio li vivono, e che di real vivono), gli ultimi mesi di vita di un vecchio scrittore del sud un po' rimbambito, un po' sporcaccione e un po' lucidissimo intellettuale e, infine, la carriera e la vita di un naturalista talmente geniale da azzeccare solo le note ai suoi lunghissimi e sballatissimi trattati (e non per questo, agli occhi di Sullivan, meno geniale). I quattro pezzi sul mondo musicale riguardano: il primo, la partecipazione dello scrittore (come spettatore, ovviamente) ad un festival di rock cristiano, una sorta di woodstock dei fondamentalisti cattolici americani, una di quelle manifestazioni che sono parte integrante del brodo "culturale" dei tea parties e della destra ultraconservatrice americana. Il secondo pezzo, che sfarfalla sulla vita di Michael Jackson, sulle sue indubbie doti e, pur valutando gli aspetti poco chiari e/o edificanti della sua carriera (dalla famiglia ossessionata dalla musica e, soprattutto, dai soldi che speravano di farne conseguire, alle accuse di violenza su minori), svolta verso un'interpretazione sostanzialmente positiva della persona, del personaggio e del musicista. Il terzo saggio, forse il più interessante tra i quattro e mezzo che vagolano in un modo o nell'altro nel mondo della musica, si immerge nella realtà che ha cullato l'infanzia e l'adolescenza maledetta di una rockstar come Axl Roses che, come sostiene Sullivan in apertura di articolo, "viene dal niente", ossia dall'Indiana. Poi ci spostiamo in Giamaica ad intervistare Bunny Wailer, l'ultimo dei Wailers, la prima band di Bob Mailer, trovandoci invischiati in una caccia all'uomo (un altro uomo, che coinvolge tutta l'isola e non solo, un delinquente, anche se con la propensione alla sindrome da Robin Hood). Infine, il pezzo intitolato "piedi in fumo", che è il "mezzo" dei quattro articoli e mezzo di ambito musicale, che racconta quando, il 21 Aprile del 1995, il fratello di Sullivan avvicina la bocca ad un microfono (cantava in una band) e muore. In realtà non muore, ma la scarica elettrica lo spedisce in coma e quello che segue è il racconto dei mesi in cui il fratello deve riprendere le misure al concetto stesso di esistenza e a tutti quegli aspetti (infiniti) che ne fanno parte tra cui, non ultimo, la logica causa effetto. Quest'ultimo articolo, pur se venato da una notevole ironia che solo si può permettere qualcuno coinvolto nei fatti e, immagino, col beneplacito del diretto interessato che pare aver preso bene la disavventura, riporta per certi versi, in alcune considerazioni evidenziate sul funzionamento del cervello e su come noi siamo quel cervello o, per meglio dire, siamo, nella normalità delle cose, quel funzionamento del cervello, riporta dicevo ai libri di Oliver Sacks. I libri di Sacks, a mio avviso, pur nella loro dolcezza (non saprei come definirla altrimenti) sono terrificanti incubi da svegli: le paure di Poe traslate nella realtà clinica: essere sepolti vivi in una tomba non è meglio, a mio avviso, dell'essere sepolti dentro i propri corpi privi di comando o, se volete, nelle proprie menti sbrindellate. Il racconto di Sullivan invece non arriva ad inabissare il lettore a tal punto nell'angoscia, forse semplicemente perchè la storia si conclude per il meglio e il lieto fine, come sempre, riverbera la sua luce ottimista su tutta l'oscurità che l'ha preceduto. Un po' tutta la raccolta ha questa caratteristica: racconta certi aspetti poco compatibili con l'idea che è stata venduta al mondo di american dream, ma lo fa con una (apparentemente) naturale leggerezza e un taglio ironico non sprovvisto di una certa acuta intelligenza dello sguardo (e alla diretta partecipazione dell'autore agli eventi narrati). Non ultimo, Sullivan, e con esso il suo stile, sa essere efficacemente paraculo, che è una dote che non guasta quando bisogna intrattenere degli sconosciuti su argomenti che con tutta probabilità non li interessano neanche un poco. Non so se sia la raccolta di saggi più importante dall'epoca dell'uscita di Una cosa divertente che non farò mai più, di Foster Wallace, e non credo che sia il nuovo Hunter Thompson, ma è sicuramente un ottimo esempio di New Journalism. E un bel libro da leggere. Anche divertente. Sul lato oscuro dell'America e via discorrendo.
John Jeremiah Sullivan è nato a Louisville, Kentucky, nel 1974. Collabora con il New York Times Magazine ed è editor della Paris Review. Ha esordito con Blood Horses, un resoconto storico e culturale dell’industria delle corse dei cavalli.
John Jeremiah Sullivan è nato a Louisville, Kentucky, nel 1974. Collabora con il New York Times Magazine ed è editor della Paris Review. Ha esordito con Blood Horses, un resoconto storico e culturale dell’industria delle corse dei cavalli.
Etichette:
Americani,
ensayos,
John Jeremiah Sullivan,
Libros,
Sellerio
Iscriviti a:
Post (Atom)